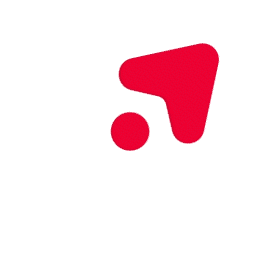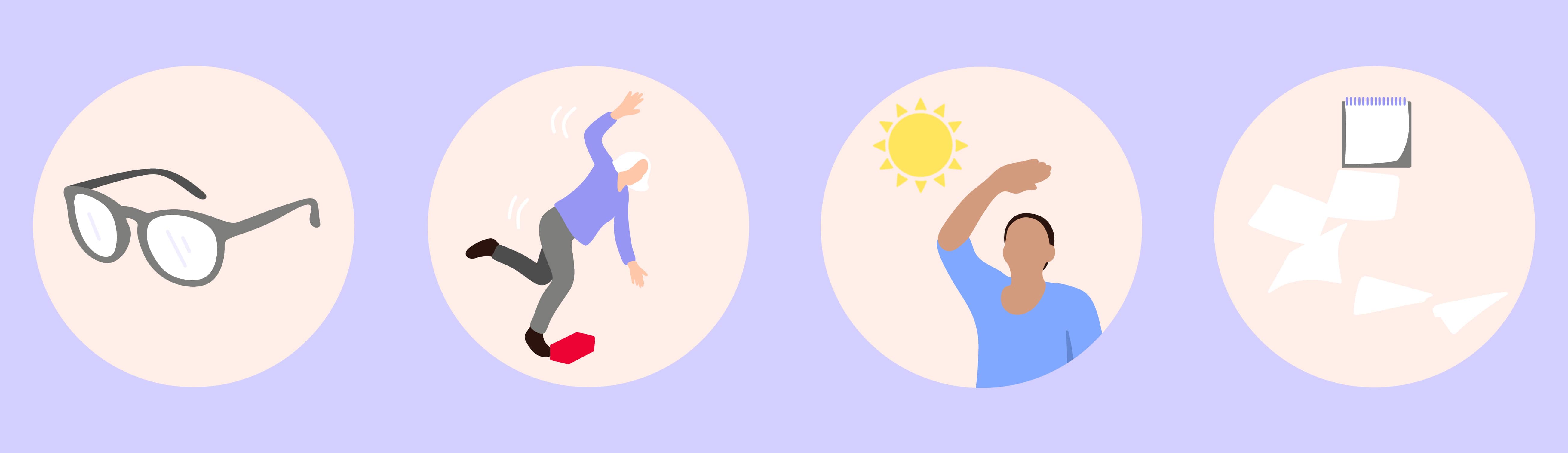Cataratta: sintomi, trattamento e cause

Rapida introduzione ai nostri temi
La cataratta è una malattia dell'occhio che provoca l'annebbiamento del cristallino dell'occhio, limitando (oscurando) la visione. I colori sono spesso percepiti in modo meno intenso. Se non trattata, la malattia può portare in alcuni casi alla cecità. L'intervento chirurgico è l'unico modo per trattare la cataratta. La lente oculare annebbiata viene rimossa e sostituita con una nuova lente artificiale.
Che cos'è la cataratta?
La cataratta (o ipòchima) è una malattia degli occhi in cui il cristallino diventa sempre più opaco, infatti le persone affette da cataratta vedono l'ambiente circostante come attraverso un velo di nebbia. A causa di ciò, la visione diventa sfocata e la capacità di vedere diminuisce. Se la malattia progredisce e non viene curata, in alcuni casi si può arrivare alla cecità. Di solito sono colpiti entrambi gli occhi, anche se a volte l'annebbiamento progredisce più rapidamente da un lato rispetto all'altro. Ne sono spesso affette le persone anziane, con età superiore ai 60 anni: si parla infatti anche di "cataratta senile".
L'opacità non interessa necessariamente l'intero cristallino, ma può essere limitata a singole aree. Ciò consente di suddividere la malattia nei seguenti sottotipi:
- Cataratta corneale: quando soprattutto la parte anteriore del cristallino è annebbiata. Sua particolare manifestazione è il fatto che la luce viene rapidamente percepita come accecante.
- Cataratta subcapsulare: si intende che l'opacità si trova sotto la capsula del cristallino (cioè sotto l'involucro della lente). L'opacità spesso progredisce rapidamente e ne sono colpite spesso persone giovani.
- Cataratta nucleare: in questo caso, le persone colpite hanno spesso difficoltà a vedere chiaramente in lontananza. L'annebbiamento di solito progredisce lentamente.
Quali sono i sintomi della cataratta?
La cataratta si manifesta con una riduzione della vista. Inizialmente si rileva una miopia e le persone che prima erano ipermetropi possono tornare a vedere meglio senza occhiali. Tuttavia, questo cambiamento è di breve durata e si manifesta finché la visione continua a diminuire. La cataratta progressiva e la conseguente riduzione della vista aumentano il rischio di cadute e lesioni.
Con il tempo, anche l'intensità dei colori diminuisce e le persone colpite reagiscono in modo più sensibile alla luce intensa: la luce del sole, ad esempio, viene percepita come abbagliante e sgradevole, mentre quando si guida di notte i fari delle auto che si incrociano diventano una luce accecante. La causa e la localizzazione dell'opacità influenzano i sintomi; ad esempio, nella cataratta corneale, la luce è percepita come accecante.
I sintomi si manifestano gradualmente e le persone colpite di solito non avvertono alcun dolore. Il deterioramento della vista viene inizialmente compensato con gli occhiali. Tuttavia, con il progredire dell'annebbiamento, questi spesso non sono più sufficienti. Senza trattamento, la malattia può portare alla cecità.
Come si sviluppa la cataratta?
Il cristallino è una parte dell'apparato visivo ed è fondamentale per generare un'immagine nitida sulla retina; quando si annebbia, la visione non è più chiara e le immagini risultanti sono come circondate da un alone. In alcuni soggetti il cristallino si annebbia rapidamente, mentre in altri il processo è più lento. La causa esatta della cataratta non è ancora stata chiarita, ma diversi fattori giocano un ruolo importante:
- Età
- Malattie metaboliche come il diabete
- Predisposizione genetica
- Malattie concomitanti a malattie ereditarie
- In conseguenza di una precedente malattia o lesione oculare, oppure di un'infiammazione oculare
- Carenza di nutrienti fondamentali
- Assunzione prolungata di alcuni farmaci, come il cortisone
- Miopia grave
- Radiazioni (raggi X, luce UV).
In alcuni casi, la cataratta è congenita. Le probabilità aumentano soprattutto se la futura madre contrae la rosolia o il morbillo durante la gravidanza.
Come fa il medico a diagnosticare la cataratta?
Per diagnosticare la cataratta si eseguono diversi esami oculistici. I test visivi servono a determinare se e quanto la vista sia compromessa: per identificare la causa esatta del deterioramento della vista e determinare o escludere la cataratta, il medico utilizza la cosiddetta lampada a fessura (o biomicroscopio). Grazie al fascio di luce, il medico rende visibili il cristallino e la retina e, se è presente una cataratta, il cristallino appare di colore grigio-giallo. Questa colorazione grigia dà il nome alla cataratta.
Per esaminare bene la parte posteriore dell'occhio, a volte è necessario utilizzare un collirio prima dell'esame, il cui scopo è dilatare le pupille e facilitare tale esame indolore. Il collirio spesso provoca una percezione offuscata dell'ambiente circostante per alcune ore e per questo motivo è vietato mettersi alla guida in tale intervallo di tempo. Si tratta di esami per i quali è quindi consigliabile portare con sé dal medico un accompagnatore.
Come si cura la cataratta?
L'annebbiamento del cristallino non scompare da solo e quindi la cataratta non può essere curata. Inoltre, non esistono farmaci per trattare la malattia. L'unica terapia possibile è l'intervento chirurgico (estrazione della cataratta): essa consiste nel rimuovere il cristallino e sostituirlo con un nuovo cristallino artificiale. La chirurgia della cataratta è uno degli interventi più comunemente eseguiti in Europa. Dopo l'intervento, il paziente riceve un collirio antibiotico, da applicare seguendo un preciso schema.
Si distingue tra diversi metodi chirurgici:
- Rimozione extracapsulare: in questa tecnica, la capsula del cristallino (l'involucro in cui è inserito il cristallino) viene aperta mediante una piccola incisione e il cristallino viene rimosso e sostituito. È la procedura più applicata.
- Rimozione intracapsulare: una tecnica utilizzata meno frequentemente. Viene applicata soprattutto in presenza di un'ulteriore lesione oculare che abbia modificato la posizione naturale del cristallino. In questo caso, l'intera capsula del cristallino viene rimossa e sostituita.
Per ogni procedura, esistono due modi per rimuovere il cristallino danneggiato. Questi sono:
- Ultrasuoni: viene praticata una piccola incisione per accedere al cristallino, che viene poi frantumato e aspirato mediante ultrasuoni.
- Laser: sia il taglio che la frantumazione del cristallino sono effettuati con il laser.
Con entrambe le tecniche chirurgiche, di solito non è necessario suturare le incisioni, essendo piccole.
Per eseguire l'intervento è necessario un anestetico locale, che viene somministrato sotto forma di collirio o di iniezione vicino all'occhio. Solo in rari casi si ricorre all'anestesia generale.
L'intervento in sé dura circa 10 minuti per occhio e di solito viene effettuato in regime ambulatoriale, per cui i pazienti possono tornare a casa il giorno stesso. Viene operato un solo occhio alla volta e, se la cataratta interessa entrambi gli occhi, le lenti vengono solitamente operate in due procedure separate in due giorni consecutivi o a distanza di alcuni mesi.
Un intervento chirurgico è sempre associato a determinati rischi. Ad esempio, durante l'intervento di cataratta è possibile che alcune aree dell'occhio, come la capsula del cristallino, l'iride e il bulbo oculare, vengano danneggiate. Il rischio dipende anche dalla presenza di altre patologie (oculari). È comunque buona norma chiarire con il proprio medico eventuali preoccupazioni e concordare il calendario dell'intervento.
Tuttavia, la procedura è un intervento di routine e viene eseguita senza rischi nella maggior parte dei casi, quindi senzacomplicazioni. In casi rari e gravi si verificano complicazioni come il distacco della retina e/o l'infezione. Potrebbe verificarsi un'infezione se dei batteri penetrano nell'occhio durante l'operazione; verrà quindi trattata con antibiotici.
Dopo l'intervento, l'occhio viene coperto per alcuni giorni se il secondo occhio non viene operato il giorno successivo, per lasciarlo a riposo. È possibile che l'occhio e la zona del viso circostante si gonfino e prudano; tuttavia, nella maggior parte dei casi il fastidio sparirà da solo. Potrebbero essere necessarie alcune settimane o addirittura alcuni mesi per ottenere una visione completa con la nuova lente. Si tenga presente che il grado di danno del cristallino non influisce sulla visione mediante la nuova lente.
Subito dopo l'intervento, i pazienti non devono guidare l'auto per alcuni giorni, mentre potranno riprendere rapidamente la loro abituale routine quotidiana. È consigliabile chiarire direttamente con il medico quali attività saranno di nuovo praticabili e a partire da quando. Inoltre, verranno organizzate diverse visite di controllo con il medico per continuare a monitorare gli occhi. In alcuni casi si verifica la cosiddetta post-cataratta: ciò significa che la capsula del nuovo cristallino si intorbidisce e quindi provoca nuovamente i sintomi. La post-cataratta viene trattata con un laser in un breve intervento, durante il quale la capsula del cristallino intorbidita viene aperta in modo che la luce torni a raggiungere senza ostacoli sulla retina, per produrre immagini nitide.
Il medico chiarirà con il paziente i diversi tipi di lenti e quale sia la più adatta a lui. Inoltre, degli esami preliminari determineranno l'acutezza visiva che la lente deve avere per ripristinare la visione. Di norma, non c'è il rischio che la nuova lente artificiale si annebbi di nuovo, quindi di solito durerà per tutta la vita.
Cosa si può fare da soli con la cataratta?
Poiché l'età è di solito la causa della cataratta, l'annebbiamento del cristallino non può essere prevenuto. Tuttavia, molti fattori di rischio possono essere ridotti al minimo:
- Indossare occhiali da sole per proteggere gli occhi.
- Se state assumendo farmaci contenenti cortisone, parlate con il vostro medico per vedere se ci sono alternative.
- Assicuratevi di condurre uno stile di vita sano e, se siete fumatori, cercate di smettere.
Se la cataratta è già stata diagnosticata, è opportuno fissare appuntamenti regolari con il medico per monitorarne la progressione e decidere se e quando sia opportuno un intervento chirurgico.
Pubblicato il: 17.04.2025
____________________________________________________________________________________________________________________________
Il nostro controllo di qualità

«Promuovere l'innovazione e il cambiamento per migliorare la vita delle persone è una mia grande preoccupazione. La salute dei nostri clienti mi sta molto a cuore ed è per questo che sostengo la guida insieme al mio team».
In qualità di responsabile del team farmaceutico all'interno del servizio di consulenza farmaceutica, Sarah Handrischeck assiste la nostra azienda e i nostri clienti fornendo risposte a domande su vari argomenti connessi alla salute. Le guide di Redcare consentono di trasmettere informazioni sintetiche ai farmacisti e di educare su importanti argomenti di salute.